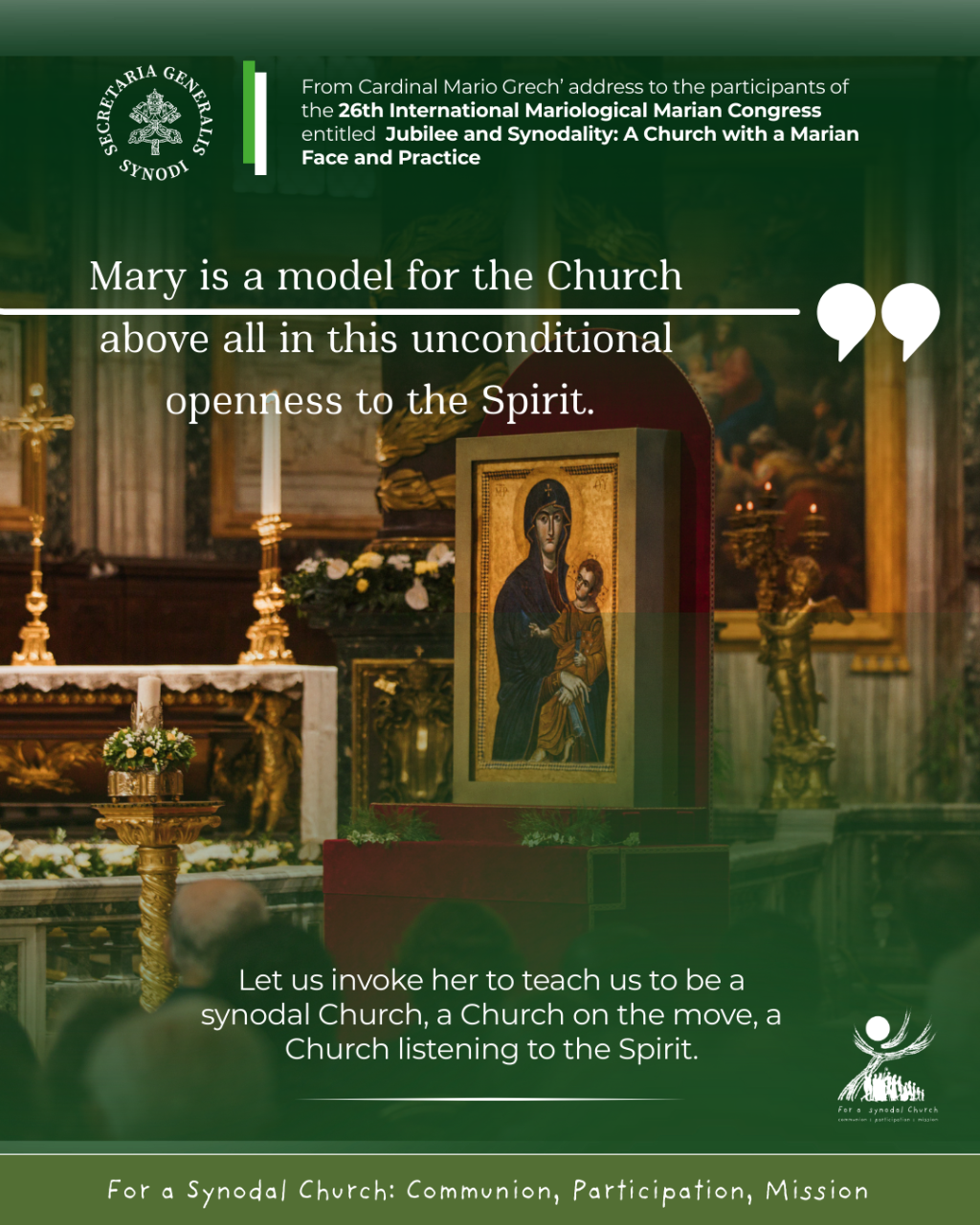
Presentiamo di seguito il contributo offerto dal Cardinale Mario Grech, Segretario Generale della Segreteria Generale del Sinodo, ai partecipanti al 26° Congresso Mariologico Mariano Internazionale su Giubileo e Sinodalità: una Chiesa dal volto e dalla prassi mariana.
Ampi stralci del discorso del cardinale sono stati pubblicati nell'edizione del 4.09.2025 dell'Osservatore Romano.
****
Con il cammino sinodale avviato da Papa Francesco nel 2021 e giunto ormai alla sua terza fase, la sinodalità è stata nuovamente intesa come una dimensione costitutiva della Chiesa. Lo stile sinodale esprime la natura della Chiesa come Popolo di Dio in cammino verso il Regno, convocato dallo Spirito Santo per annunciare la Buona Novella fino ai confini del mondo. Indicando «l’ascolto reciproco, il dialogo e il discernimento comunitario» (Documento finale [DF] 28) come elementi essenziali del cammino sinodale, la Chiesa è chiamata ad aprirsi allo Spirito Santo per riscoprire la propria dimensione sinodale e missionaria.
Molto è stato scritto sulla sinodalità e la Chiesa sinodale e missionaria. D’altra parte, dire che «la Chiesa è costitutivamente sinodale» impegna a ripensare tutti gli ambiti della vita ecclesiale dentro questo orizzonte. Tra i tanti ambiti che vanno ripensati in chiave sinodale, uno tra i meno esplorati è certamente quello relativo alla dimensione mariana della Chiesa sinodale. Se «Maria è tipo della Chiesa», come asserivano i Padri e come il Vaticano II ha ribadito nel capitolo VIII di Lumen Gentium, che implicazioni derivano da questo rapporto – anch’esso costitutivo, al punto che possiamo parlare di dimensione mariana della Chiesa – al tema della sinodalità?
Nel momento in cui riconosciamo il ruolo di Maria nella vita ecclesiale e nella devozione dei fedeli, emerge una reale necessità di approfondire il mistero mariano per comprendere più pienamente la Chiesa sinodale e missionaria. Un inizio di riflessione in proposito si trova nel Documento finale, che richiama la figura di Maria in quattro distinti passaggi: non pochi, se si pensa che la finalità principale del Documento finale non è stata certo quella di approfondire la dimensione mariana della Chiesa. I riferimenti nel testo sottolineano l’importanza di questa dimensione per la Chiesa sinodale e missionaria.
1. Il primo riferimento a Maria si trova al n. 17 del Documento finale, che afferma: «Incorporati in questo Popolo per la fede e il Battesimo, siamo sostenuti e accompagnati dalla Vergine Maria, “segno di sicura speranza e di consolazione” (LG 68)» (DF 17).
In questo passaggio, viene sottolineata l’identità della Chiesa come Popolo santo di Dio, fondata nel Battesimo. È la parte più decisiva del tempo, perché fissa il quadro ecclesiologico di riferimento per la sinodalità, vale a dire la Chiesa come Popolo di Dio, visto come sacramento di unità. Chi conosce il Concilio non faticherà a percepire qui una novità enorme: la saldatura dei capitoli I e II di Lumen Gentium, con la scelta di attribuire alla Chiesa-Popolo di Dio (descritta nel capitolo II della costituzione) l’affermazione che «la Chiesa è in Cristo come un sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità del genere umano» (LG 1), in genere attribuito alla Chiesa-mistero (descritta nel capitolo I).
È subito chiaro che qui è in gioco un’ermeneutica del Concilio Vaticano II che prova a comporre temi che nel post-concilio sono stati interpretati in termini divisivi. Chi non ricorda le tesi che contrapponevano il Popolo di Dio alla gerarchia? Il carisma all’istituzione, la “Chiesa dal basso” alla “Chiesa dall’alto”? Si capisce alla luce di quella contrapposizione la lunga stagione dell’ecclesiologia di comunione, che ha voluto arginare quella deriva, al prezzo di cassare come ideologica la categoria biblica di Popolo di Dio. Il pontificato di Francesco ha recuperato il riferimento al «santo Popolo fedele di Dio», legando strettamente la comunione alla sinodalità: la sinodalità è la forma della comunione nella Chiesa-Popolo di Dio.
Il Documento finale rappresenta il punto di arrivo di un processo di superamento delle contrapposizioni. In questa parte è proposta una sintesi ecclesiologica che compone in unità tutti gli elementi dell’ecclesiologia conciliare. Si evidenzia che la Chiesa è il Popolo di Dio, e questo Popolo, descritto come «soggetto comunitario e storico della sinodalità e della missione», è chiamato a vivere la propria vocazione escatologica nel suo «camminare insieme» verso il compimento del Regno di Dio.
In questo cammino verso la perfetta comunione con Dio, ossia la piena realizzazione del disegno di Dio per l’umanità, la Chiesa sinodale – cioè il Popolo di Dio in cammino – riconosce in Maria la perfezione a cui è destinata. Da un lato, è proprio questa prospettiva escatologica ad alimentare la speranza e l’impegno della Chiesa nel cammino verso la perfezione; dall’altro, è la Vergine Maria che, nel suo mistero, costituisce la certezza del compimento glorioso di tale cammino in Dio.
2. Il secondo richiamo mariano del Documento finale si colloca nel contesto in cui il Documento definisce il concetto della sinodalità. Anche questa parte è fondamentale per la comprensione della Chiesa sinodale. Il testo afferma al n. 28:
«La sinodalità è il camminare insieme dei Cristiani con Cristo e verso il Regno di Dio, in unione a tutta l’umanità; orientata alla missione, essa comporta il riunirsi in assemblea ai diversi livelli della vita ecclesiale, l’ascolto reciproco, il dialogo, il discernimento comunitario, il formarsi del consenso come espressione del rendersi presente di Cristo vivo nello Spirito e l’assunzione di una decisione in una corresponsabilità differenziata» (DF 28).
In questo specifico contesto, il Documento finale presenta Maria come figura della Chiesa sinodale, missionaria e misericordiosa. Afferma il testo:
«Nella Vergine Maria, Madre di Cristo, della Chiesa e dell’umanità, vediamo risplendere in piena luce i tratti di una Chiesa sinodale, missionaria e misericordiosa. Ella è infatti la figura della Chiesa che ascolta, prega, medita, dialoga, accompagna, discerne, decide e agisce. Da Lei impariamo l’arte dell’ascolto, l’attenzione alla volontà di Dio, l’obbedienza alla Sua Parola, la capacità di cogliere il bisogno dei poveri, il coraggio di mettersi in cammino, l’amore che aiuta, il canto di lode e l’esultanza nello Spirito. Per questo, come affermava san Paolo VI, “l’azione della Chiesa nel mondo è come un prolungamento della sollecitudine di Maria”» (MC 28) (DF 29).
In altre parole, il Documento finale sottolinea che la Chiesa è chiamata a riconoscere in Maria le qualità fondamentali per una sinodalità autentica; la capacità di ascolto, di preghiera, di dialogo, di discernimento, di obbedienza, di umiltà e di servizio. Questi elementi costituiscono le caratteristiche essenziali per una comunità ecclesiale che cammina nel rispetto reciproco e nella corresponsabilità. A sostegno di questa osservazione, è possibile richiamare i tre episodi del Nuovo Testamento che illustrano l’esempio di Maria in rapporto al cammino sinodale della Chiesa:
1) Nel racconto dell’Annunciazione, all’angelo Gabriele che le annuncia la maternità divina, Maria dà il suo libero consenso, che scaturisce dal suo ascolto attento e dalla sua umile obbedienza. Questi atteggiamenti di Maria rappresentano le qualità fondamentali della Chiesa sinodale e missionaria chiamata in primo luogo ad ascoltare «ciò che lo Spirito dice alla Chiesa», per mettersi al servizio dell’opera salvifica di Cristo.
2) Nel racconto della Visitazione, emerge una dinamica di incontro, di ascolto e di condivisione che contribuisce a definire ulteriormente il cammino sinodale della Chiesa; in tale episodio, infatti, viene narrato come l’incontro tra Maria ed Elisabetta, entrambe sensibili all’azione dello Spirito Santo, favorisca la condivisione e la testimonianza della presenza di Dio e della sua opera salvifica. La Chiesa sinodale è invitata a imparare dal loro esempio, diventando sempre più aperta all’azione dello Spirito Santo per promuovere incontri di ascolto e di condivisione finalizzati al bene comune della Chiesa e del mondo.
3) Nel racconto delle nozze di Cana, la Madre di Dio non solo percepisce e discerne i bisogni della comunità – in particolare la mancanza di vino – ma manifesta piena fiducia nell’intervento di Gesù, sostenendo i servi ad adempire il loro ruolo nel disegno di Dio. In questo esempio di Maria, la Chiesa sinodale è chiamata a discernere insieme attraverso lo Spirito Santo le necessità della comunità ed adottare decisioni sagge, favorendo la partecipazione e la corresponsabilità del Popolo di Dio.
4) Ma questi tre episodi si illuminano alla luce di un quarto evento: Maria ai piedi della Croce, fedele fino in fondo al cammino del Figlio che ricompone la comunione dell’uomo con Dio attraverso la kenosi «fino alla morte, e alla morte di croce» (Fil 2,8).
Meditare i misteri della salvezza attraverso gli occhi di Maria – magari nella recita del Rosario – è una via privilegiata per maturare e interiorizzare gli atteggiamenti che hanno caratterizzato la sua vita e che non possono mancare in una Chiesa sinodale.
3. In questa ottica, i due ultimi richiami del Documento finale indicano a una Chiesa che voglia dirsi sinodale sull’esempio di Maria, la via maestra. Nella seconda parte del Documenti finale, dedicato alla “conversione delle relazioni” nella Chiesa, si afferma: «Nel giorno di Pentecoste, nel Cenacolo era presente Maria, la Madre di Dio» (DF 60). Similmente, l’ultimo paragrafo dell’intero Documento finale afferma:
«Alla Vergine Maria, che porta lo splendido titolo di Odigitria, Colei che indica e guida il cammino, affidiamo i risultati di questo Sinodo. Lei, Madre della Chiesa, che nel Cenacolo ha aiutato la comunità nascente ad aprirsi alla novità di Pentecoste, ci insegni a essere un Popolo di discepoli missionari che camminano insieme: una Chiesa sinodale» (DF 155).
Da queste due citazioni emerge come una Chiesa sinodale sia una Chiesa della Pentecoste, una Chiesa costantemente in ascolto dello Spirito Santo. La duplice sottolineatura richiama quanto ripeteva Papa Francesco: nel cammino sinodale «il protagonista è lo Spirito Santo»! La sinodalità indica il camminare insieme della Chiesa, radicato profondamente nella Pentecoste perché lo Spirito Santo che scese sugli apostoli e su Maria è il principio che unisce la Chiesa e la guida nella sua missione. In questo rapporto fondamentale tra lo Spirito Santo e la Chiesa sinodale, il mistero di Maria non solo ci guida ad accogliere il dono di Dio, ma anche a divenire i portatori di tale dono in forma di servizio e di testimonianza.
4. Il legame fecondo tra Maria e la Chiesa sinodale si colloca in stretto rapporto con l’insegnamento del Concilio Vaticano II, in particolare con la costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium. Uno dei momenti più determinanti nella storia redazionale della costituzione fu la decisione dei Padri conciliari di inserire un capitolo su Maria nella costituzione come ottavo e ultimo capitolo. Questa scelta mirava a superare la teologia dei privilegi che aveva esaltato, nel corso del secondo millennio, la singolarità eminente di Maria, per ristabilire il suo legame con il mistero di Cristo e quello della Chiesa. Inoltre, la scelta dei Padri conciliari di comprendere Maria in stretto legame con l’ecclesiologia conciliare alla luce del Ressourcement, del ritorno alle fonti, intendeva promuovere un arricchimento reciproco tra ecclesiologia e mariologia sulle orme dei Padri della Chiesa.
La lezione conciliare è purtroppo ancora lontana dall’essere compresa. La mancanza di una recezione matura del rapporto tra Maria e la Chiesa, capace di interpretare la figura di Maria in una relazione costitutiva con la Chiesa nelle sue varie dimensioni, rappresenta ancora oggi una sfida per l’ermeneutica conciliare. Per evitare il rischio di ridurre il rapporto tra Maria e la Chiesa a quello tra Maria e il singolo fedele in termini troppo individualistici e devozionali, è necessario che la Chiesa contemporanea riscopra il paradigma mariano della Chiesa sinodale e missionaria alla luce dell’eredità del Concilio Vaticano II. Il che significa che dobbiamo chiederci: che cosa possiamo imparare da Maria per crescere come Chiesa sinodale? Questo capitolo dell’ecclesiologia sinodale è tutto da scrivere. A differenza di altri aspetti, che possono essere sviluppati attraverso l’argomentazione teologica, per quanto riguarda la dimensione mariana della Chiesa sinodale sarà necessario soprattutto uno sguardo contemplativo. Se il capitolo VIII di Lumen Gentium ha offerto una prospettiva tipologica, è contemplando la persona di Maria, la sua vita, le sue virtù, che la Chiesa potrà sviluppare in prospettiva sinodale il suo esempio.
5. La prima dimensione che la Chiesa è chiamata a sviluppare sull’esempio di Maria è senza dubbio quella dell’ascolto: di Dio, dello Spirito, degli altri. Se la Chiesa sinodale «è una Chiesa dell’ascolto» (Francesco, Discorso nel 50° del Sinodo), la Madre di Gesù è l’esempio più fulgido. Tutti gli episodi del Nuovo Testamento che ci parlano di Maria, sono esempi di ascolto e obbedienza. Maria ha ascoltato Dio e la sua Parola, l’ha conservata nel suo cuore e l’ha meditata (cf. LG 57-58; DF 29). Si tratta di un ascolto fondato su un profondo silenzio interiore. In una società e in una Chiesa spesso contraddistinte da un’elevata quantità di parole e azioni, Maria ci insegna il valore fondamentale del silenzio interiore, condizione essenziale per un autentico discernimento. Il suo silenzio non è vuoto, né indifferente o estraneo, ma costituisce un’espressione di profonda comunione con Dio, ricco di presenza e di contemplazione. Il silenzio di Maria è un silenzio che ascolta, che medita, che discerne e che dialoga; un silenzio che dà priorità a Dio e alla sua Parola e si traduce in obbedienza alla sua volontà.
Nel contesto del cammino sinodale della Chiesa, il silenzio rappresenta uno spazio privilegiato per accogliere il dono dello Spirito Santo; infatti, solo una Chiesa che ascolta e medita la volontà di Dio può divenire luogo di testimonianza della presenza viva dello Spirito Santo. Di conseguenza, in una Chiesa sinodale che si fonda sull’ascolto dello Spirito e sull’ascolto reciproco, la Vergine Maria si presenta come modello di silenzio e di ascolto, perché colei che ha saputo ascoltare Dio, la realtà circostante e gli altri, ha incarnato nella propria persona la vocazione stessa della Chiesa sinodale e missionaria. Analogamente a quanto avvenne nel giorno di Pentecoste, quando la comunità fu chiamata ad ascoltare, accogliere e mettere in pratica ciò che lo Spirito del Cristo risorto donò, oggi la Chiesa sinodale e missionaria è chiamata a riscoprire il valore del mistero di Maria per camminare insieme come Popolo santo di Dio verso il Regno di Dio, nella comunione vissuta, nella partecipazione condivisa e nella missione corresponsabile, anche grazie alla intercessione di Maria Odigitria, che indica e guida il nostro cammino.
6. Oltre alla dimensione dell’ascolto, vorrei provare ad offrire qualche cenno su due dimensioni della Chiesa sinodale che in genere non si collegano alla figura di Maria: quella missionaria e quella ecumenica e chiudere il mio contributo con un richiamo al tema delle donne.
Per sviluppare la dimensione missionaria della Chiesa sinodale in chiave mariana non bisogna cedere alla tentazione di applicare a Maria tutti gli aspetti della missione. Sono gli Apostoli che vanno a predicare il Vangelo fino ai confini del mondo. Questo non esclude la dimensione mariana della missione! In realtà, Maria insegna alla Chiesa che non esiste missione senza la preghiera incessante. Non si comprende la missione che a partire dal Cenacolo, dove la Chiesa è raccolta con Maria in obbedienza alla parola di Gesù: «Giovanni battezzò con acqua: voi, invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. […] riceverete la forza dello Spirito santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,5. 7).
Il primo evangelizzatore nella Chiesa è lo Spirito Santo! È lui che sostiene e sospinge gli Apostoli a predicare il Vangelo; è Lui che li rende capaci di parresía fino al dono totale di sé. Per questo deve incessantemente salire dalla Chiesa l’invocazione perché Dio doni lo Spirito Santo ai suoi Apostoli. E se diciamo che ogni battezzato è un «discepolo missionario», come usava dire Papa Francesco, dobbiamo al contempo sottolineare che la missione avviene a condizione dello Spirito. La presenza di Maria nel Cenacolo come madre e membro della Chiesa è un costante richiamo a questa dimensione pneumatologica della Chiesa, chiamata a “stare” prima che ad “andare”. D’altra parte, dove potrebbe mai andare la Chiesa, cosa potrebbe mai annunciare il Vangelo senza la forza dello Spirito Santo?
D’altro canto Maria stessa, adombrata dallo Spirito Santo, è divenuta la Theotokos e ha dato Gesù al mondo, come ancora ricorda Lumen Gentium al numero 63. E vi è un modo prettamente sinodale in cui i cristiani, imitando lei, possono anch’essi donare Gesù al mondo: quando per l’amore reciproco fra loro, attirano la presenza viva del Risorto, secondo il dettato evangelico: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18,20). Quale miglior dono può fare la Chiesa a se stessa (in ogni adunanza, celebrazione, incontro, anche qui ora), se non meritare la presenza viva del Risorto? Quale miglior dono per uscire in missione nelle strade del mondo, tra la gente, ovunque, portando Gesù, donando Gesù, come Maria?
7. Un’altra dimensione su cui vorrei soffermarmi è quella ecumenica. Anche in questo caso sembrerebbe che non esistano particolari punti di contatto con la dimensione mariana della Chiesa. Laddove però pensiamo alla Chiesa come «l’assemblea di coloro che credono e guardano a Gesù autore della salvezza e principio di unità e di pace» (LG 9), e a Maria come la Madre della Chiesa, comprendiamo come non si possano separare le due dimensioni. Più di qualche Padre conciliare espresse il suo disappunto per questo titolo, proposto da Paolo VI nel discorso di chiusura della terza sessione del Concilio. Il motivo addotto era ecumenico, soprattutto per la contrarietà della teologia protestante alla teologia dei privilegi, che poneva Maria sopra la Chiesa. Al contrario, il titolo rafforza la pari dignità di tutti i battezzati, mostrando come il titolo più grande di appartenenza alla Chiesa è l’essere figlio. E figli siamo fatti nell’unico Battesimo, che ci unisce in una fraternità che è più forte di qualsiasi divisione.
D’altra parte, Lumen Gentium si conclude proprio con un riferimento che addirittura travalica l’orizzonte ecumenico per rivolgere la sua attenzione a tutta l’umanità:
«Tutti i fedeli cristiani elevino insistenti preghiere alla Madre di Dio e madre degli uomini, perché Ella, che ha aiutato con la sua preghiera gli inizi della Chiesa, interceda presso il suo Figlio anche adesso che si trova in cielo innalzata sopra tutti i beati e gli angeli nella comunione dei santi; fino a quando tutte le famiglie dei popoli, tanto quelle insignite del nome cristiano come quelle che ignorano il loro Salvatore, vengano felicemente riunite in pace e concordia nell’unico Popolo di Dio, a gloria della santissima e indivisa Trinità» (LG 69).
8. Concludo con un tema che in realtà è un’apertura. Maria è donna. Il tema delle donne è emerso con forza del processo sinodale, dalla prima all’ultima tappa. Il Documento finale dedica il paragrafo 60 al tema delle donne nella Chiesa. Afferma che «in forza del Battesimo, uomini e donne godono di pari dignità nel Popolo di Dio». Riconosce che, purtroppo, «le donne continuano a trovare ostacoli nell’ottenere un riconoscimento più pieno dei loro carismi, della loro vocazione e del loro posto nei diversi ambiti della vita della Chiesa, a scapito del servizio alla comune missione». È in questo paragrafo – come si è già visto – che si richiama la presenza di Maria nel Cenacolo «insieme ad altre donne che avevano seguito il Signore» nel giorno di Pentecoste.
Il Documento finale prova poi a valorizzare le forme di presenza delle donne nella Chiesa di oggi e ad aprire un orizzonte più ampio sulla loro partecipazione attiva alla vita e alla missione della Chiesa, senza dimenticare le questioni aperte come, ad esempio, «l’accesso delle donne al ministero diaconale». Una frase risulta particolarmente significativa: «Non ci sono ragioni che impediscano alle donne di assumere ruoli di guida nella Chiesa: non si potrà fermare quello che viene dallo Spirito Santo».
A me pare che la sfida che presenta la partecipazione della donna nella missione della Chiesa si giochi sul terreno di un consenso che può e deve maturare nell’ascolto dello Spirito. È facile arroccarsi su argomenti di Tradizione per difendere uno status quo che perpetuerebbe un modello di Chiesa clericale, o pretendere un allineamento della Chiesa alle tesi della cultura contemporanea. Questa divaricazione è facilmente applicata anche alla figura di Maria, per la quale si ribadiscono categorie come Sposa e Madre per ribadire compiti della donna legati a una società patriarcale, o si rifiuta la sua stessa figura, perché non si riesce a declinare compiutamente nelle categorie della parità di genere.
Il discorso è delicato e può caricarsi di valenze ideologiche, da una parte e dall’altra. In ambedue i casi si rischia di strumentalizzare e decurtare gravemente la figura di Maria, che tuttavia resiste alle ragioni dell’una e dell’altra parte. Bisogna applicare al discorso tanto delle donne che di Maria i principi di una corretta ermeneutica teologica, istituendo una circolarità virtuosa tra i dati certi della Scrittura e della Tradizione e quelli contestuali: quelli sono sempre ulteriori e irriducibili a questi, e tuttavia possono ricevere nuova luce dalla situazione attuale.
Per fare questo bisogna avere molta pazienza e non bisogna procedere per semplificazioni né per strappi. Affermare posizioni che non abbiano raggiunto un consenso vero nella Chiesa significa polarizzare il corpo ecclesiale ed esporlo a rischi di divisioni; rifiutarle a priori significa chiudersi al dinamismo della Tradizione, che progredisce sotto l’azione dello Spirito Santo. La via più certa è quella dell’ascolto. Il Concilio ci ricorda che «cresce la comprensione tanto delle cose quanto delle parole trasmesse sia con la contemplazione e lo studio dei credenti, i quali le meditano in cuor loro (cfr Lc 2,19 e 51), sia con la profonda intelligenza delle cose spirituali di cui fanno esperienza, sia con la predicazione di coloro che, con la successione apostolica, hanno ricevuto un carisma certo di verità» (DV 8).
I versetti evangelici richiamati dal testo conciliare si riferiscono a Maria: la Chiesa è chiamata allo stesso atteggiamento di ascolto. Ascolto dello Spirito e ascolto dei segni dei tempi (cfr GS 4). Leggere i passi evangelici che si riferiscono alla Madre di Dio può aiutare a comprendere più a fondo non solo la presenza delle donne nella Chiesa, ma la realtà stessa delle donne e, per richiamare il titolo di un noto libro, “al femminile dell’essere”. Istituire una circolarità virtuosa tra antropologia e mariologia non può che giovare alla causa delle donne. Soprattutto può liberare da visioni riduttive di ostinata chiusura o di apertura sconsiderata. Decidere se e in quale misura aprire o chiudere non dipende da noi e dalle nostre convinzioni, ma dallo Spirito che guida la Chiesa a tutta la verità (cfr Gv 16,13) e la conduce a maturare un consenso vero anche sul tema della pari dignità nella Chiesa. D’altra parte, «non si potrà fermare quello che viene dallo Spirito Santo» (DF 60).
Maria è modello della Chiesa soprattutto in questa apertura incondizionata allo Spirito. Invochiamola perché ci insegni ad essere Chiesa sinodale, Chiesa in cammino, Chiesa in ascolto dello Spirito.
Card. Mario Grech, Segretario generale

